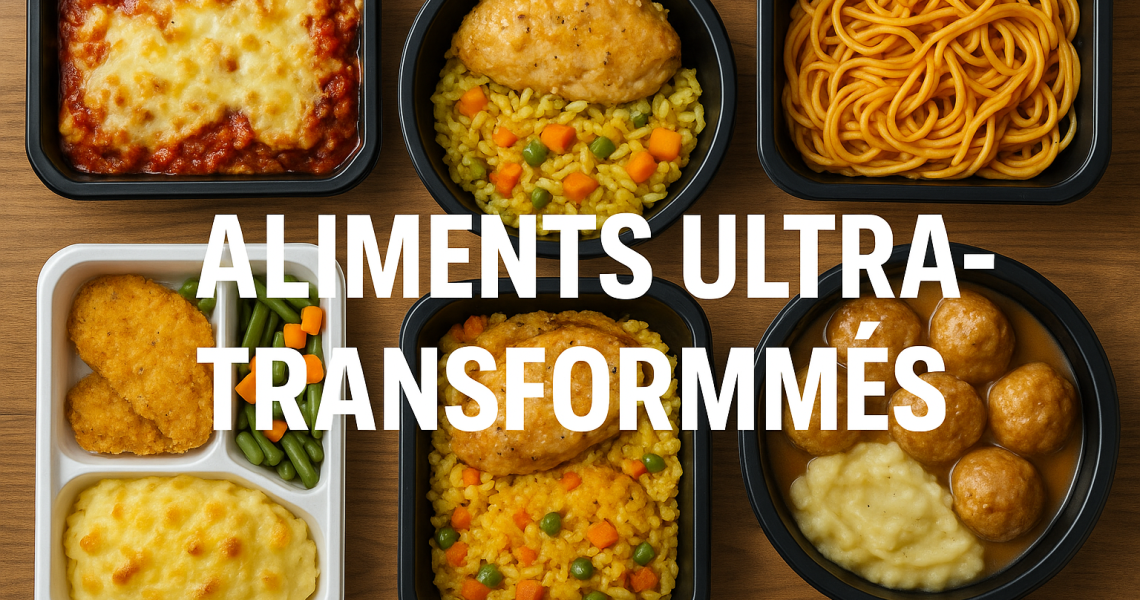Ogni giorno sentiamo dire che i “cibi ultra-lavorati” sono responsabili dei nostri mali: obesità, malattie cardiovascolari, diabete, ecc. Ma se questa demonizzazione fosse troppo semplicistica? Un recente studio britannico su larga scala mette in discussione questa visione dominante, dimostrando che forse la colpa non è tanto del grado di elaborazione, quanto piuttosto delle nostre percezioni, convinzioni ed emozioni. In questo articolo scoprirai che:
- Cosa significa “ultra-lavorato”
- Cosa suggeriscono le ultime ricerche
- Perché le nostre rappresentazioni mentali possono superare la classificazione industriale
- Implicazioni per le politiche di salute pubblica
- Modi pratici per agire nella vita di tutti i giorni
Il mio obiettivo? Fornirti una visione sfumata, rigorosa e attuabile, non un semplice slogan.
1. Cosa intendiamo davvero per “alimenti ultra-lavorati”?
La classificazione NOVA: utile ma contestata
Il sistema NOVA, spesso utilizzato nell’alimentazione pubblica, divide gli alimenti in quattro gruppi in base al loro grado di lavorazione industriale. Il quarto gruppo comprende gli alimenti “ultra-lavorati”: prodotti industriali ricchi di additivi, zuccheri, aromi, stabilizzanti, ecc. (bevande dolci, barrette di cioccolato, piatti pronti, ecc.).
Ma questa categorizzazione ha i suoi limiti:
- Mescola prodotti molto diversi tra loro nello stesso cestino (ad esempio bevande zuccherate, sostituti vegetali riformulati);
- Non tiene conto della variabilità nutrizionale all’interno di questa categoria;
- Non tiene conto del fascino sensoriale, delle abitudini culturali o dei contesti di consumo.
Perché questa categoria è diventata il “nemico pubblico numero 1”?
Da diversi anni ormai, i media e i politici indicano gli alimenti ultra-lavorati come la principale forza trainante dell’epidemia di obesità, malattie cardiovascolari e persino disturbi cognitivi. Il risultato: etichette di avvertimento, restrizioni pubblicitarie, tasse, divieti di vendita in determinate aree – tutto basato sul presupposto che “più il cibo è lavorato, più è dannoso”.
Ma la scienza si sta evolvendo.
2. Nuovo studio, nuove prospettive: cosa rivela la ricerca britannica
Un team di ricercatori ha esaminato le risposte di oltre 3.000 adulti britannici che sono stati messi di fronte a 400 cibi raffigurati in fotografie. Il loro obiettivo era quello di misurare il loro “apprezzamento” del cibo (ciò che trovavano piacevole) e la loro propensione al sovraconsumo edonico (cioè mangiare oltre il punto di sazietà).
Risultati principali
- La classificazione NOVA spiega solo il 2% delle differenze di gradimento tra gli alimenti e il 4% dei comportamenti di consumo eccessivo.
- D’altra parte, gli attributi percettivi (gusto, consistenza, grassi, dolcezza) e le convinzioni che gli individui hanno su un alimento (ad esempio “è industriale/naturale/artificiale/salutare/calorico”) rappresentano una percentuale molto più elevata.
- Quando un alimento viene percepito come “altamente elaborato”, è più probabile che venga consumato senza ritegno, anche se ciò non è giustificato dalla sua reale composizione.
- Combinando i dati nutrizionali (41%) e le credenze/percezioni (37%), i ricercatori sono riusciti a prevedere il 78% delle variazioni nella propensione a mangiare troppo.
Cosa ci dice questo
La sola classificazione industriale (NOVA o altra) non è sufficiente a spiegare perché a volte mangiamo “troppo” di un alimento. Le nostre rappresentazioni mentali – ciò che crediamo, sentiamo e prevediamo – giocano un ruolo fondamentale.

3. Perché le nostre convinzioni spesso prevalgono sulla classificazione
Il potere della rappresentazione
Quando un prodotto viene etichettato come “ultra-lavorato”, si scatena una reazione a catena di sensi di colpa, cibo spazzatura e pericolo. Anche un prodotto equivalente dal punto di vista nutrizionale ma percepito come “fatto in casa” o “naturale” sarà spesso meglio tollerato o addirittura consumato con meno scrupoli.
Gusto, sazietà, emozioni
Gli stessi due alimenti possono essere giudicati in modo diverso a seconda dell’ambiente, del marketing, della presentazione o persino dell’ora del giorno. I desideri emotivi (comfort, stress, convivialità) influenzano le nostre scelte.
Inoltre, riformulare un prodotto (riducendo zuccheri, grassi, sale) non è sempre sufficiente; questa riformulazione deve essere accompagnata dalla gestione del gusto, della sazietà e delle aspettative sensomotorie.

4. Cosa si dovrebbe fare per le attuali politiche nutrizionali?
Limiti degli approcci “proibiti/tassati/allarmati
- Corrono il rischio di demonizzare alimenti che possono trovare posto in una dieta equilibrata (ad esempio, cereali arricchiti, sostituti proteici).
- Possono confondere il pubblico in generale dando segnali contraddittori (un prodotto trasformato ma una “opzione sana”?).
- Non affrontano le dimensioni psicologiche, sociali e culturali delle abitudini alimentari.
Verso un’alimentazione più intelligente e contestualizzata
I ricercatori suggeriscono tre aree chiave su cui concentrarsi:
- Educazione alimentare: insegnare alle persone non solo a leggere le etichette, ma anche a capire i propri segnali di fame, le proprie voglie e i contesti in cui si mangia.
- Riformulazione ragionata: progettare prodotti più sazianti e meno iperappetitosi, preservando il piacere di gustarli.
- Tenere conto delle motivazioni alimentari: riconoscere che mangiare è anche un atto emotivo, sociale e legato all’identità, non solo un bisogno fisiologico.
5. Vita quotidiana: cosa possiamo fare?
- Prediligi gli alimenti minimamente elaborati, ma senza eccessivi sensi di colpa: un prodotto elaborato può trovare il suo posto.
- Coltiva la consapevolezza delle tue percezioni: metti in discussione ciò che senti quando vedi “ultra-trasformato”.
- Mangia in un contesto favorevole: senza stress, senza distrazioni, con consapevole moderazione.
- Introduci varietà, consistenze e piatti fatti in casa quando possibile.
- Fai attenzione alle “diete semplicistiche” e alle punizioni psicologiche che a volte accompagnano le ingiunzioni alimentari.
Conclusione:
Il nostro rapporto con il cibo è più complesso della semplice opposizione “trasformato/non trasformato”. Lo studio britannico dimostra che le nostre convinzioni, sensazioni e rappresentazioni mentali giocano un ruolo fondamentale nel nostro comportamento.
Per le politiche pubbliche e per le nostre scelte quotidiane, la sfida consiste nell’abbandonare una visione manichea per adottare un approccio più sfumato, basato sull’educazione, sulla comprensione psicologica, sulla riforma intelligente e sul rispetto del piacere.